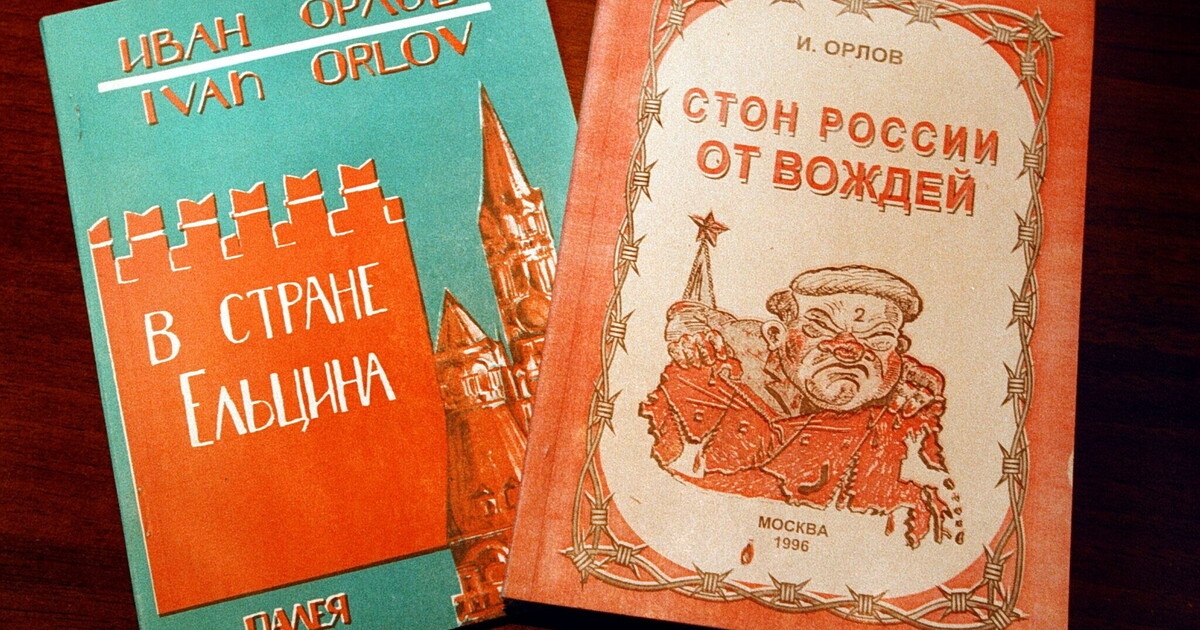'La morte dello jus belli', Cacciari alla Biennale lancia l'allarme

"Tutto non torna come prima quando hai messo a morte i principi fondamentali della tua cultura". Con questa frase, pronunciata con tono grave e lucido, Massimo Cacciari è intervenuto questa sera alla Biennale di Venezia con una delle sue lectio magistralis più dure e profetiche, "La morte dello jus belli. Le guerre e la pace". Introdotto dal presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, che ha presentato questo nuovo evento della Biennale della Parola, e dal saluto del patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia, il filosofo ha intrecciato le riflessioni di Immanuel Kant ("Per la pace perpetua") e Ernst Jünger ("La pace - Una parola ai giovani d'Europa e ai giovani del mondo") in un discorso che è insieme analisi politica, diagnosi morale e appello civile.
La tesi di Cacciari è netta: la guerra di oggi ha cancellato ogni distinzione tra militare e civile, tra lecito e illecito, tra guerra e sterminio. "Non c'è più nessuno jus in bello. Dove stanno i militari, sta la popolazione civile. E insieme sono il nemico. È una guerra assoluta, una guerra di sterminio", ha detto Cacciari.
Il filosofo veneziano ha denunciato una trasformazione radicale del conflitto, che segna una rottura storica con ogni precedente. Se in passato anche le guerre più feroci riconoscevano, almeno formalmente, limiti e regole, oggi - sostiene Cacciari - quel fragile baluardo è crollato del tutto. Non si combatte più contro eserciti, ma contro popoli interi; non contro avversari politici, ma contro la loro esistenza stessa. Da qui la domanda di fondo: che ne è del diritto internazionale, del "diritto alla pace", quando la guerra diventa assoluta?
Per Cacciari, l'Europa sta smarrendo le proprie radici giuridiche e morali, illudendosi che tutto possa tornare come prima una volta "eliminato il nemico", Ma così facendo, avverte, "crolla non solo il diritto, ma la stessa civiltà europea".
L'appello finale è affidato alle nuove generazioni. Toccherà a loro - ha detto Cacciari - tentare di ricostruire un tessuto umano, sociale e culturale capace di fondare di nuovo un diritto internazionale. "Appare un compito pressoché impossibile, ma è un compito necessario. Le generazioni presenti e passate hanno fallito: solo una diagnosi spietata può restituire speranza".
E quella speranza, ammette il filosofo, non è di questo tempo: "La speranza è oltre oggi, è oltre le montagne più impervie. Ma senza di essa, senza la consapevolezza di ciò che abbiamo distrutto, non potrà nascere alcuna pace". Con "La morte dello jus belli", Cacciari non ha solo commentato la cronaca delle guerre contemporanee - da Gaza all'Ucraina - ma ha messo in questione la coscienza stessa dell'Europa, la sua fede nel diritto, nella ragione, nella distinzione tra umanità e barbarie. Un monito che suona come una sentenza, ma anche come l'ultimo appello possibile: "ricominciare a pensare il diritto" prima che sia troppo tardi.
In apertura dell'evento, il presidente Buttafuoco ha ricordato che la Biennale di Venezia deve essere un laboratorio di parola libera, un argine alla rimozione di temi oggi quasi "proibiti" nel dibattito pubblici, come la guerra o la pace. Buttafuoco ha poi evocato con nostalgia l'intellettuale cattolico Giorgio La Pira e il parlamentare comunista Pio La Torre, due figure simboliche di un'Italia che sapeva unire fede e impegno civile, dialogo e conflitto. "Ricordo l'Italia di La Pira, che chiamava a Firenze i nemici da tutto il mondo per parlare di pace, e quella di Comiso, con Pio La Torre e milioni di persone mobilitate. Oggi, figure così sarebbero trattate come nemici pubblici, privati del diritto di parola".
Un passaggio che suona come una critica severa alla chiusura del dibattito contemporaneo, dove la complessità e il confronto sembrano aver ceduto il passo alla semplificazione e all'intolleranza. Per questo Buttafuoco ha riaffermato la missione della Biennale: custodire la libertà del pensiero e difendere la parola come strumento di conoscenza e non di propaganda. "La Biennale lavora in funzione della parola - ha detto - e siamo orgogliosi di ciò che ogni giorno si somma nel nostro lavoro".
In un tempo segnato da guerre e tensioni globali, il patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia, prima della lezione di Cacciari ha offerto una riflessione profonda sul tema della pace e della guerra, invitando a guardare oltre la politica e le istituzioni per riscoprire la dimensione spirituale e morale della pace. Moraglia ha ricordato come il mondo di oggi sia "dominato da espansionismi e da nuove tecnoscienze applicate persino all'industria bellica". Di fronte a questo scenario, il patriarca ha evocato l'attualità del progetto kantiano delineato nel trattato "Per la pace perpetua", dove il filosofo tedesco immaginava la nascita di un organismo giuridico internazionale capace di porre fine ai conflitti attraverso la forza del diritto. Ma la riflessione di Moraglia non si è fermata alla teoria. "Possiamo avere le migliori leggi e i migliori strumenti, ma se manca il pilota, il viaggio non può compiersi", ha osservato, alludendo alla crisi degli organismi internazionali come le Nazioni Unite e alla mancanza di volontà politica e morale che impedisce alla pace di radicarsi. Nel suo intervento, il patriarca ha richiamato anche il concetto di "strutture di peccato", quelle realtà e dinamiche sociali che perpetuano l'ingiustizia e la violenza, spesso mascherandole dietro altri nomi. La guerra, ha detto, "non sempre si chiama guerra, ma continua sotto altre forme". Il cuore del messaggio di Moraglia è però antropologico: la pace non nasce dalle leggi, ma dal cuore dell'uomo. Citando il filosofo russo Nikolaj Berdjaev, ha ricordato che "la verità cristiana presuppone la libertà" e che il male non si vince con la forza dello Stato, ma con una vittoria interiore, spirituale. "Lo Stato può limitare la violenza, ma non può estirpare il peccato", ha aggiunto. Moraglia ha concluso con un appello alla responsabilità personale e collettiva: "Il bene non è il risultato delle sole leggi, ma della libertà che sceglie il bene. È necessario ripartire dall'uomo, dalla sua complessità, dalle sue ferite e dalla sua capacità di rinnovarsi". Solo un'umanità riconciliata con sé stessa - ha aggiunto - potrà trovare "la grazia di vivere nella verità e costruire una pace autentica". (di Paolo Martini)
Adnkronos International (AKI)