Gilberto Freyre aveva in parte ragione
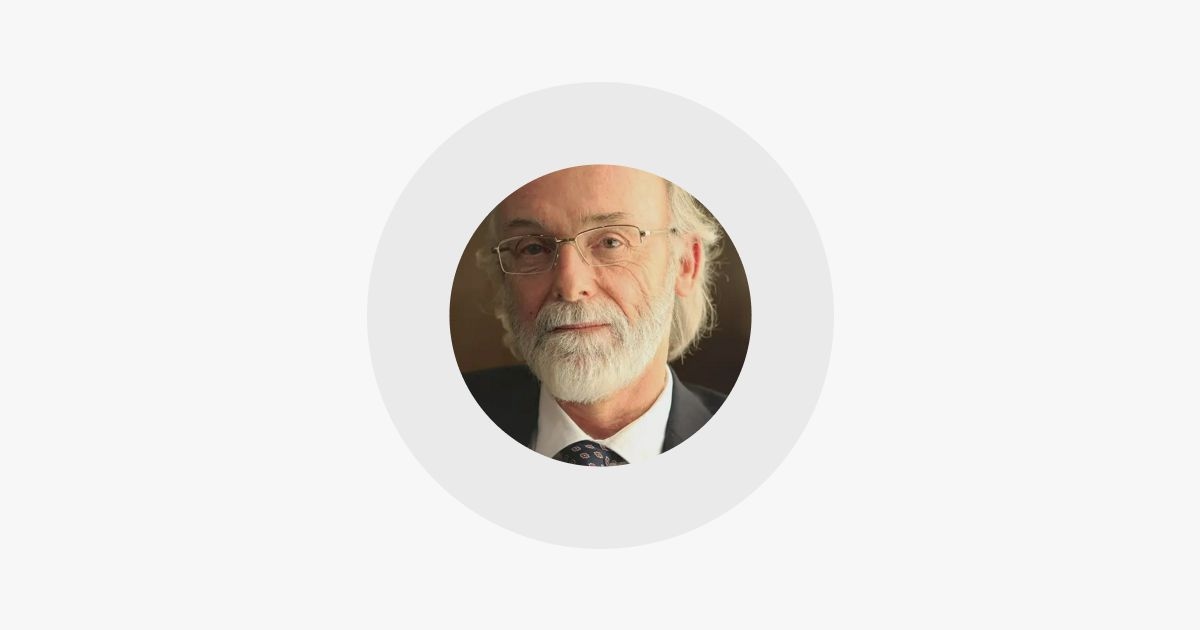
Il termine lusotropicalismo è solitamente associato a Gilberto Freyre, autore di Casa Grande e Senzala (1933), il che è giustificato, poiché è stato questo sociologo brasiliano a utilizzarlo per la prima volta e a sviluppare un'intera teoria che, fondamentalmente, sostiene che i neri, gli indiani e, infine, anche gli asiatici, hanno dato un contributo molto importante alla formazione del Brasile e delle altre colonie lusotropicali; che i portoghesi avevano una speciale capacità di relazionarsi e fraternizzare con gli altri popoli, in particolare quelli provenienti dai tropici; che praticavano in queste regioni un cristianesimo fraterno caratterizzato da tolleranza, gentilezza e umanità, e non avevano quasi pregiudizi razziali; e che dimostrarono una certa inclinazione alla mescolanza razziale, dando origine al meticcio, verso il quale i progenitori portoghesi avrebbero mostrato un atteggiamento di grande accettazione, cosa che, ad eccezione degli spagnoli, sarebbe rara tra i popoli europei moderni.
In sintesi, il lusotropicalismo afferma l'idea della specificità del colonialismo portoghese. Ci sarebbe un “modo portoghese di stare al mondo”, cioè un modo specifico in cui i portoghesi si relazionano con gli altri popoli e che sarebbe più gentile e più umano di quello degli altri europei.
La prima grande critica al lusotropicalismo venne da Charles R. Boxer, storico inglese ed ex militare, il quale, nel suo libro Race Relations in the Portuguese Colonial Empire, 1415-1825 , pubblicato nel 1963, affermò che il lusotropicalismo non aveva alcun fondamento storico, anzi. Secondo Boxer, i portoghesi, lungi dall'essere un'eccezione, erano razzisti quanto gli altri europei. L'inglese contestò anche l'idea che i portoghesi avessero avuto un modo tollerante e gentile di relazionarsi con le popolazioni dei tropici, che ci fosse stata un'integrazione armoniosa, sottolineando, invece, la loro violenza e il loro comportamento discriminatorio nei confronti dei popoli colonizzati. Il meticciato effettivamente osservabile nei possedimenti portoghesi non significherebbe l'assenza di pregiudizi basati sul colore, ma sarebbe semplicemente una conseguenza della mancanza di donne bianche. Invece di amare la mescolanza razziale, ciò che si sarebbe verificato, in larga misura, sarebbe stato lo stupro.
Bersaglio di questa e di altre critiche, legate all'Estado Novo, che da un certo punto in poi lo sfruttò in modo palese sia dal punto di vista ideologico che politico, il lusotropicalismo cadde in disgrazia e finì per essere considerato un corpus teorico del tutto fuorviante. La sinistra, soprattutto, in quanto paladina del postcolonialismo, cioè della lotta contro le idee che il colonialismo ha creato sui popoli colonizzati, l'ha ridicolizzata, schiacciata e gettata nel cestino delle idee. Di più. Fischiava e cercava di sminuire chiunque osasse difenderlo. Cinque anni fa José Ribeiro e Castro si dichiarò lusotropicalista. Ha spiegato che “il lusotropicalismo non è negazionismo o conformismo”, bensì “uno strumento fondamentale: un popolo che ha l’idea di sé come non razzista si impegna a non esserlo, a reprimere tutto ciò che offende questo codice etico e a portare sempre più avanti questo impegno”. Fu subito contraddetto dalla storica Cláudia Castelo, che vedeva in Ribeiro e Castro la personificazione dell'effetto che la propaganda salazariana e lusotropicalista avrebbe avuto sulla mente delle persone, ovvero vedeva in lui un esempio dello "stato di illusione e pigrizia mentale (sic) che aveva creato l'Estado Novo". Secondo Cláudia Castelo, l'ex presidente del CDS sarebbe “il risultato consapevole e pacificato (sic) dell'efficacia dell'apparato politico-ideologico dell'Estado Novo (…) nella propaganda di un'immagine essenzialista del popolo portoghese con tratti positivi, nell'esaltazione di una presunta eccezionalità della colonizzazione portoghese e nell'inclusione di una norma (ma non di una pratica) antirazzista”.
C'è un tono arrogante di commiserazione nell'articolo di Cláudia Castelo per José Ribeiro e Castro e per coloro che, come lui, si sarebbero limitati — secondo la storica — a ripetere senza criterio ciò che l'Estado Novo aveva instillato in loro negli anni Cinquanta e Sessanta. E con questo tipo di dura invettiva, con questa anatemizzazione delle menti dissenzienti, la sinistra crede di aver finalmente risolto il problema. Tuttavia, è più persistente perché ha qualcosa di sottostante che è osservabile e talvolta misurabile. In effetti, alcune delle idee di Freyre si fondano su fondamenta a loro precedenti e sono, qua e là, confermate dalla ricerca attuale: sono state proprio queste informazioni più recenti a spingermi a scrivere questo articolo.
Cominciamo dalle origini antiche per sottolineare che alcune delle convinzioni di Gilberto Freyre erano già state avanzate da altri nel XVIII e XIX secolo, forse anche prima, non solo in Portogallo, ma anche all'estero. Chiunque legga l' Histoire philosophique et politique des Deux Indes , opera collettiva del 1772 attribuita all'abate Raynal, troverà valutazioni positive — in termini relativi, bisogna intenderlo — sulla colonizzazione portoghese. Questo tipo di valutazione si ritrova anche in De la littérature des nègres , un libro dell'abbé Grégoire pubblicato nel 1808, in cui si esprime l'idea che, rispetto ai popoli dell'Europa settentrionale, i portoghesi (e gli spagnoli) trattavano meglio gli indigeni e liberavano gli schiavi e i neri. Nel 1819, colui che a volte viene definito il primo socialista portoghese, Francisco Solano Constâncio, affermò, negli Annaes das Sciencias, das Artes e das Letras , che ci sarebbe stato un sistema portoghese di relazioni con i neri, un sistema che avrebbe costituito il culmine delle relazioni del Portogallo con l'Africa e che si riassumeva nello "spirito di gentilezza e fraternità" con cui, in generale, il Portogallo aveva trattato le nazioni indigene, nelle quali aveva introdotto, "con mezzi gentili", il cristianesimo e le conoscenze tecniche che allora possedeva. Mentre diversi autori stranieri consideravano gli africani come animali destinati per natura alla schiavitù, il sistema portoghese, istituito fin dall'inizio, accettava come principio che i neri fossero "uomini come i bianchi", suscettibili di istruzione.
Queste e altre idee simili continuarono a essere espresse per tutto il XIX secolo, in particolare nel suo ultimo quarto, da persone che - e presumo che Cláudia Castelo non mi contraddirà - non furono mai soggette alle inculcazioni ideologiche dell'Estado Novo. Anche le menti di numerosi storici stranieri contemporanei — ora mi soffermerò sui più recenti — non furono plasmate dagli ideologi e dai propagandisti di Salazar. Tuttavia, questi storici non possono fare a meno di notare che c'era qualcosa di diverso nel modo in cui il Portogallo si rapportava ai tropici. Come sottolinea uno di loro, dopo tre secoli di occupazione coloniale olandese in Indonesia, nessuno parla olandese lì, a differenza di quanto accade in alcune parti del mondo in cui il Portogallo è stato presente per lo stesso periodo di tempo. Anche in un contesto così negativo e tragico come la tratta transatlantica degli schiavi, c'era quello che David Eltis, forse la massima autorità attuale in questo ambito storico, chiama "il sistema portoghese" che lo differenziava dagli altri.
In peggio? Apparentemente no, e ciò si riflette nel numero molto basso di rivolte a bordo delle navi portoghesi e brasiliane: solo 11 su un totale di 572 già identificate, in netto contrasto con le 488 ribellioni a bordo delle navi britanniche, francesi, olandesi e danesi. Un altro dato illustrativo: solo il 12% del numero totale di schiavi trasportati nelle Americhe partì dalla zona di Senegambia-Guinea, ma fu su queste navi che ebbe luogo il 40% delle rivolte a bordo (nessuna di queste, tuttavia, avvenne su navi in partenza dai porti portoghesi di Bissau e Cacheu).
Queste quantità bassissime, o addirittura nulle, non sono il risultato di un miracolo o di un caso, ma piuttosto delle specificità del “sistema portoghese”, le specificità che Gilberto Freyre e altri prima di lui hanno sottolineato. Il fatto è che molti membri dell'equipaggio delle navi negriere che partivano dalle città portoghesi o brasiliane erano schiavi o ex schiavi, alcuni dei quali speravano di acquistare prigionieri in Africa per poi rivenderli in Brasile. Il punto importante, però, non è questo, bensì il fatto che, a differenza di quanto accadeva sulle navi negriere provenienti dal Nord Europa, questi marinai erano neri e, in molti casi, parlavano le lingue degli sventurati che dovevano essere imbarcati. Questo era molto importante perché aiutava a rassicurarli. È importante tenere presente che in Africa si era diffusa la terrificante convinzione che l'imbarco equivalesse a un passaggio verso la terra dei morti, dove i bianchi avrebbero massacrato i neri e utilizzato i loro corpi. La sua pelle sarebbe stata usata per fare scarpe, le sue ossa per produrre polvere da sparo, la sua carne per il cibo, i suoi arti schiacciati per produrre olio, ecc. Non è difficile immaginare il terrore che provavano al pensiero di ciò che li attendeva. Ora, quando videro tra l'equipaggio delle navi persone come loro che erano già state dall'altra parte dell'Atlantico e che da lì erano tornate sane e salve, il livello di inquietudine, disperazione e potenziale di rivolta diminuì notevolmente.
Questi erano fatti che attestavano, anche nella loro forma più orribile, la specificità del rapporto del Portogallo con l'Africa. Ma naturalmente ce n'erano anche altri che lo differenziavano dal rapporto dei danesi, dei francesi e degli altri nordeuropei con quel continente. Basti pensare, infatti, che questi europei non avevano, all’epoca della tratta transatlantica degli schiavi, e a differenza dei portoghesi, i cosiddetti “lanciati”, cioè uomini che si lanciavano, che rischiavano la vita, per vivere con i neri, risiedendo tra loro al di fuori delle direttive della Corona e, talvolta, della stessa civiltà cristiana. Nel XV secolo furono fondati diversi insediamenti portoghesi dal Senegal alla Sierra Leone, ma processi simili si verificarono anche nel Congo e, più tardi, in Angola, dove, a partire dalla seconda metà del XVI secolo, i più audaci o meno fortunati si infiltrarono nell'entroterra in cerca di affari. Vivendo come gli indigeni, questi avventurieri furono i primi europei a tropicalizzarsi e ci furono casi in cui riuscirono a sposare i leader locali, dando vita a una simbiosi luso-africana. Queste sono le prime radici del lusotropicalismo e fu su queste e su altre che Gilberto Freyre teorizzò e, in parte, ebbe ragione. Sì, la colonizzazione portoghese ebbe aspetti eccezionali.
observador


![[Articolo] Controcorrente: il ruolo dei leader nella difesa dell’ESG](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fwww.noticiasustentavel.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F05%2FAndre-Lavor-1.jpg&w=1280&q=100)


