In Portogallo gli affitti sono stati congelati 115 anni fa
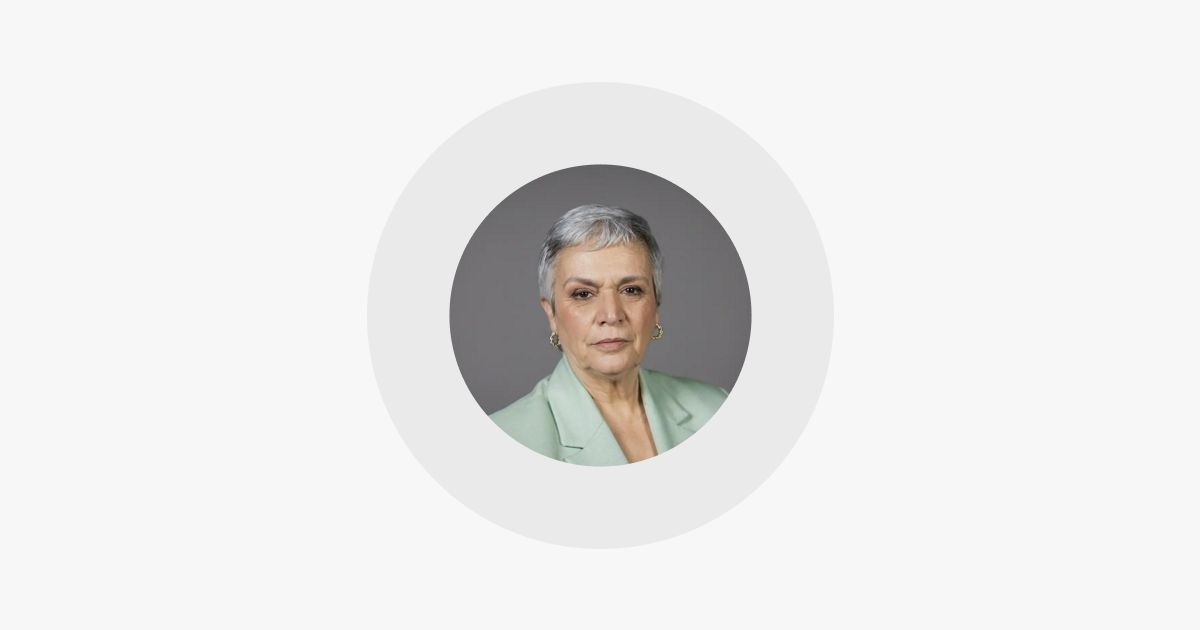
Qualcuno scoprirà che il calo delle nascite può essere combattuto assumendo battaglioni di cicogne? Probabilmente no. Ma quando si parla di leasing, gran parte della legislazione approvata è altrettanto inverosimile, se non di più, dell'immagine di bambini che nascono dai becchi delle cicogne.
Pertanto, e tenendo conto che oggi viviamo in un'epoca in cui non possiamo dire ciò che pensiamo, ecco una cronologia di quanto è accaduto in questi 115 anni in termini di leasing. Inoltre, presto avremo elezioni locali e presidenziali e, chissà, anche quelle legislative, quando arriverà il momento. Tuttavia, vi consiglio di non leggerlo tutto in una volta, perché correreste il rischio di scoppiare a ridere o a piangere quando ricompariranno parole come "congelamento" o "soffitto".
1910 – Istituzione della Repubblica il 5 ottobre. Pubblicazione, il 14 novembre, del decreto del 12 novembre che, all'articolo 9, congela i canoni di locazione per un anno.
1914 – Il decreto 1079 del 23 novembre estende il blocco degli affitti a tutto il Paese e alle isole adiacenti, lasciando esclusi solo gli affitti più alti, come nel 1910. Questo decreto, all’articolo 3, stabilisce anche l’obbligo penale di affittare le case sfitte, con un canone di affitto pari a quello dell’ultimo contratto.
1918 – Il 29 giugno viene emanato il decreto 4499 che, oltre a continuare a specificare gli sfratti, associa il blocco degli affitti allo stato di guerra: “Finché dura lo stato di guerra e fino a un anno dopo la firma del trattato di pace, è espressamente vietato ai proprietari e ai subaffittuari di aumentare l’ammontare degli affitti”.
1919 – La guerra finì nel 1918, ma in Portogallo permanne la situazione eccezionale delle case in affitto o affittabili: il 17 aprile, il decreto 5411 mantenne il congelamento, dissociandolo da condizioni eccezionali come lo stato di guerra. Il blocco degli affitti non è più l'eccezione, ma la regola.
1920 – Il 18 agosto viene approvata la legge 1020. Una legge in cui lo Stato legislatore protegge lo Stato inquilino: “Nessuna azione di sfratto può essere intrapresa da edifici urbani di cui lo Stato è inquilino”.
1923 – Il 10 settembre viene emanato il decreto 9118. Questo decreto stabilisce, all'articolo 7, che gli affitti fino a quel momento congelati potranno essere aumentati. In parole povere, i coefficienti autorizzati sono molto più bassi rispetto all'aumento registrato negli anni precedenti del costo della vita e dei salari.
1928 – Il 30 marzo viene emanato il decreto 15 289. Ciò apre la possibilità di aumentare alcuni affitti, anche se a valori inferiori all'aumento dei prezzi. Tuttavia, il 4 aprile, un nuovo decreto, il 15 315, ha annullato gli articoli che miravano ad ampliare la portata delle eccezioni al congelamento.
1943 – Invocando i casi abusivi di aumenti dei canoni di locazione e di sfratti effettuati ai sensi del decreto 15 289, il 22 gennaio 1943 venne emanato il decreto 32 638, che stabiliva il blocco dei canoni aumentati ai sensi del decreto 15 289 e la sospensione degli sfratti non ancora eseguiti.
1948 – Il 22 giugno viene approvata la legge 2030. In sostanza, allineava il valore degli affitti al valore patrimoniale dell'immobile, ovvero al reddito lordo ad essi attribuibile, rispetto al 1937. Gli affitti delle abitazioni potevano essere nuovamente aggiornati tramite una rivalutazione fiscale, vietata a Lisbona e Porto. Questa situazione persisterà fino al 1985.
1969 – Il consigliere Gonçalves Pereira, su ordine del ministro della Giustizia, prepara uno studio concludendo che i redditi erano compresi tra un quinto e un quarto del valore che avrebbero avuto se avessero seguito la svalutazione della moneta.
1974 – Il decreto legge 217/74 del 27 maggio stabilisce all’articolo 9: “Gli affitti degli edifici urbani sono congelati per trenta giorni ai livelli praticati il 24 aprile scorso”. Quattro mesi dopo, il 12 settembre, venne emanato il decreto legge 445/74. Il legislatore vede l'affitto come una sorta di male necessario temporaneo, mentre l'autocostruzione, le cooperative edilizie e l'offerta pubblica di alloggi non soddisfano la domanda. Finché non si giungerà a questa soluzione, il legislatore ha stabilito che la rivalutazione fiscale degli alloggi ai fini dell'adeguamento dei canoni di locazione resti sospesa su tutto il territorio nazionale. Viene inoltre sospeso il diritto alla demolizione, utilizzato da alcuni proprietari per superare le difficoltà negli sfratti, e viene introdotto l'obbligo di affittare gli immobili rimasti vuoti per più di 120 giorni. I canoni da richiedere nei nuovi contratti di locazione sono subordinati agli importi dei contratti precedenti. Gli aumenti percentuali previsti per i nuovi contratti danno spesso valori francamente aneddotici, soprattutto se si tiene conto degli aumenti salariali nel frattempo registrati.
1975 – Il 14 aprile 1975 viene pubblicato il decreto legge 198-A/75. Con questo decreto si legalizza l'occupazione selvaggia di edifici vuoti, obbligando i rispettivi proprietari a stipulare contratti di locazione con gli occupanti. Se non fosse possibile determinare il valore del reddito dalla tabella inserita nel decreto legge 445/74, esso varrebbe un sesto del salario minimo nazionale, che al momento dell'emanazione del decreto era ancora di 3.300 escudos, il che equivale a un reddito di 550 escudos.
1976 – Il decreto legge 420/76 regolamenta quello che può essere definito approssimativamente come diritto successorio nei contratti di locazione. Considerato che «la scadenza dei contratti di locazione di immobili residenziali, conseguente al decesso dell'inquilino, comporta spesso lo sfratto di coloro che, avendo vissuto nell'immobile locato, talvolta per diversi anni, incontrano difficoltà insormontabili nel ricollocarsi», il presente decreto stabilisce il diritto di preferenza nel nuovo contratto di locazione, non solo per i familiari diretti dell'inquilino defunto, ma anche per coloro che vivevano con lui in una economia condivisa e per gli ospiti che questi aveva ospitato nell'immobile. Ironicamente, l'affitto era diventato un buon affare per quasi tutti, tranne che per il proprietario: molti inquilini affittavano stanze e parti delle loro case a un prezzo più alto di quello pagato ai proprietari. Non solo questi ospiti potevano diventare inquilini, ma il loro diritto a un nuovo contratto di locazione sostituiva quello del proprietario che aveva bisogno dei locali per la propria abitazione.
1977 – La legge n. 63/77 concede agli inquilini di abitazioni un diritto di preferenza nell’acquisto della propria abitazione. Essere proprietari di una casa era considerata la situazione ideale, mentre affittare divenne sinonimo di arcaismo e sfruttamento.
1981 – Il decreto legge 148/81 del 25 maggio 1981 avvia una nuova fase nella legislazione in materia di locazione. Partendo dal presupposto che il fatto che gli affitti non siano stati più aggiornati dopo la stipula del contratto abbia portato a chiedere un prezzo molto alto per le poche case che sembravano essere affittate, questo decreto crea i regimi di affitto libero e condizionato. Nel primo caso, il locatore potrebbe chiedere l'importo dell'affitto desiderato in un nuovo contratto, ma non potrebbe aggiornarlo. Nel caso di un affitto condizionato, il locatore poteva richiedere un importo mensile che non superasse il 7% del valore dell'immobile, ma ogni anno poteva aggiornare tale affitto in base a coefficienti definiti con decreto governativo. Tutti i contratti conclusi prima della pubblicazione del presente decreto restano in vigore senza alcuna modifica.
1985 – Viene emanata la legge 46/85, che sarà regolamentata dal decreto legge 13/86 del 23 gennaio 1986. Ancora una volta, il legislatore cerca di aggirare gli effetti del blocco degli affitti: gli affitti sono ora sottoposti a tre regimi – affitti liberi, assistiti e condizionati – e viene stabilito che tutti gli affitti sono soggetti ad aggiornamento. Tuttavia, gli altissimi tassi di inflazione registrati dal Portogallo in quegli anni non si sono riflessi negli aumenti autorizzati degli affitti: nel 1985 l'inflazione era del 19,9 ma i coefficienti erano 1,18 per gli affitti liberi e condizionati; nel 1986 l'inflazione era dell'11,6, ma gli affitti liberi e condizionati furono aggiornati rispettivamente solo dell'1,13 e dell'1,14; nel 1987 con un'inflazione al 9,4, gli affitti furono aggiornati a 1,085 e 1,090... Risultati: gli affitti si deprezzarono di anno in anno.
1990 – Viene emanato il decreto legge 321-B/90, che istituisce il Regime di Locazione Urbana (RAU). Tale decreto, oltre a riunire la vasta normativa vigente in materia di locazione urbana, ha introdotto alcune rilevanti innovazioni, in particolare consentendo la stipula, in materia di locazione abitativa, di contratti di durata limitata. Tuttavia, poiché il credito bancario è più facile da usare per i proprietari di case e i proprietari non hanno alcuna garanzia che le tariffe autorizzate per l'aggiornamento degli affitti manterranno il passo con l'inflazione e che saranno in grado di eseguire uno sfratto in tempo utile in caso di inadempienza, affittare non è più visto come un'opzione, né dagli investitori né da coloro che cercano una casa in cui vivere.
2004 – A settembre, il Consiglio dei ministri approva la cosiddetta legge Arnault, sul Nuovo regime delle locazioni urbane (RNAU). Fortemente contestata dalle associazioni degli inquilini, che la vedevano come una precarizzazione dei contratti di affitto, con la possibilità di sfratto dopo tre anni, ha lasciato intatti gli affitti di circa 220 mila inquilini, che avevano più di 65 anni e guadagnavano meno di cinque salari minimi. Questa legge non venne mai effettivamente approvata, perché il governo che l'aveva approvata, presieduto da Santana Lopes, cadde alla fine di novembre 2004.
2006 – A febbraio è stata approvata la legge 6/2006, nota come NRAU – Nuovo regime di locazione urbana. Comprende una serie di misure volte non solo a scongelare, ma anche ad aggiornare i contratti di locazione precedenti al decreto legge 321-B/90, che ha istituito il Regime di Locazione Urbana (RAU). Nella pratica, questa legge e le modifiche introdotte dalla NRAU erano molto difficili da applicare.
2012 – La legge n. 31/2012, nota come Legge sugli affitti o Legge Cristas, cerca di porre fine definitivamente al blocco deciso oltre un secolo fa e che i governi successivi hanno cercato di aggirare dal 1981: gli sfratti vengono semplificati. Viene data maggiore libertà alle parti nello stipulare la durata dei contratti, è stato creato lo Sportello Nazionale Noleggio. Ai contratti di transizione precedenti al decreto legge 321-B/90 al nuovo regime è concesso un periodo di 5 anni.
2017 – Il governo di António Costa, con il sostegno parlamentare dell’estrema sinistra, decide di estendere il “periodo transitorio” degli affitti congelati fino al 2022. Una nuova legge renderà questi contratti a vita.
2023 – Ci sono 124.083 contratti precedenti al 1990 con un valore medio dell’affitto di 166,54 euro. È stato pubblicato uno studio che stima che questi proprietari sussidino i loro inquilini per un valore di centinaia di milioni di euro. Il governo di António Costa decide che non risarcirà i proprietari a causa del "momento politico che il Paese sta attraversando".
2024 – novembre. La proposta di Bilancio dello Stato per il 2025 prevede lo sblocco dei “vecchi affitti” (contratti di locazione antecedenti al 1990). Nel documento si stabilisce che “devono essere adottate le misure necessarie per concludere i processi di transizione” dei contratti e per “ripristinare la giustizia” nel mercato degli affitti. I dettagli di queste proposte sono rimasti a metà a causa della caduta del Governo.
2025 – A maggio l’Agenzia delle Entrate notifica a diversi proprietari di immobili con affitti congelati l’imposta IMI, un’imposta da cui la legge li ha esentati da tempo proprio perché non possono aggiornare i propri affitti. I contratti di locazione precedenti al 1990 restano congelati.
PS . Il voto del pubblico ha garantito a Israele il secondo posto all'Eurovision Song Contest. Cosa significa questo? Per ora, la tribù di “Israele fuori” dovrebbe fermarsi e riflettere, se ciò è emotivamente possibile per loro. Artisti, personalità con ego eccessivo e protagonisti in cerca di una via di fuga dal loro fallimento, come il signor Sanchez, hanno creato l'idea che Israele sia una specie di paria tra le nazioni e che le azioni militari da esso intraprese siano ingiustificate. Paradossalmente, la gente potrebbe non solo non avere la stessa opinione, ma potrebbe addirittura avere un'opinione contraria a quella espressa in questa specie di flagellazione quotidiana che sono le notizie su Gaza.
In un momento in cui la questione della sicurezza e del controllo delle frontiere è all'ordine del giorno in diversi paesi europei, il fatto che Israele cerchi di garantire la sicurezza dei suoi cittadini può essere visto come la risposta indispensabile da parte di un'opinione pubblica che non solo non ha espressione, ma che non dovrebbe nemmeno esistere. Ovviamente, la risposta di Israele non è esente da errori, fallimenti e battute d'arresto. Ma vale la pena chiedere agli europei: se il vostro Paese fosse l'obiettivo di un attacco come quello avvenuto in Israele il 7 ottobre 2023, come vi aspettereste che reagisse il vostro governo?
Sì, è ormai noto che l'Eurovision riguarda le canzoni e non la guerra. Ma qualcosa mi dice che in questa vicenda, come in tante altre, la differenza tra la bolla e il mondo è sempre più grande.
observador





