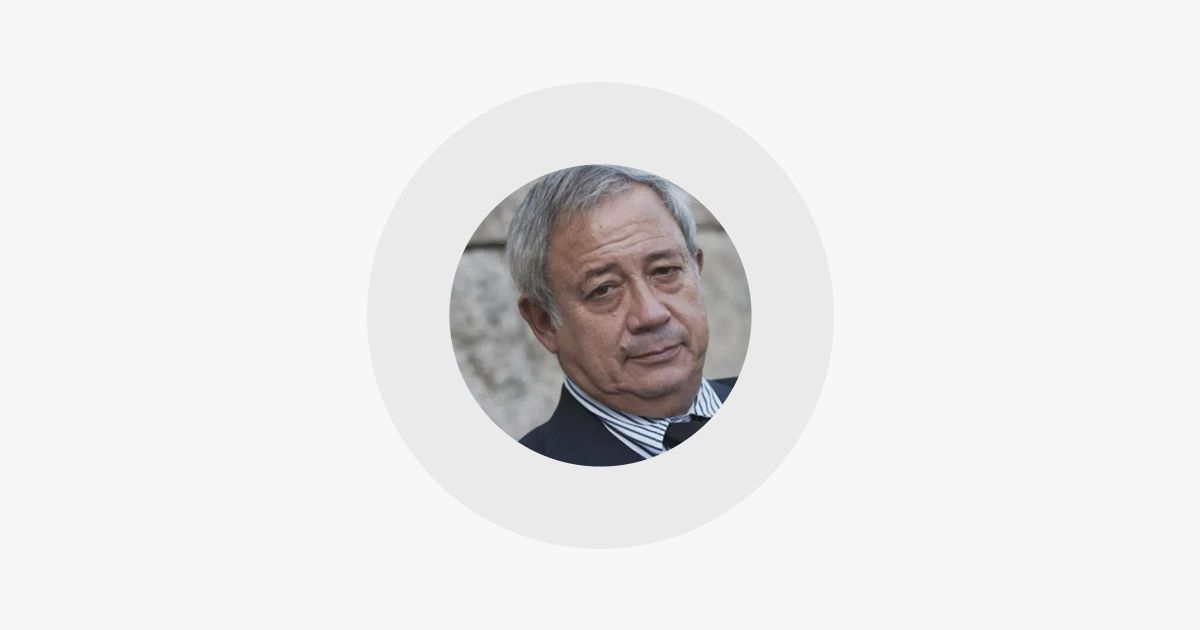La tristezza di May e Martial
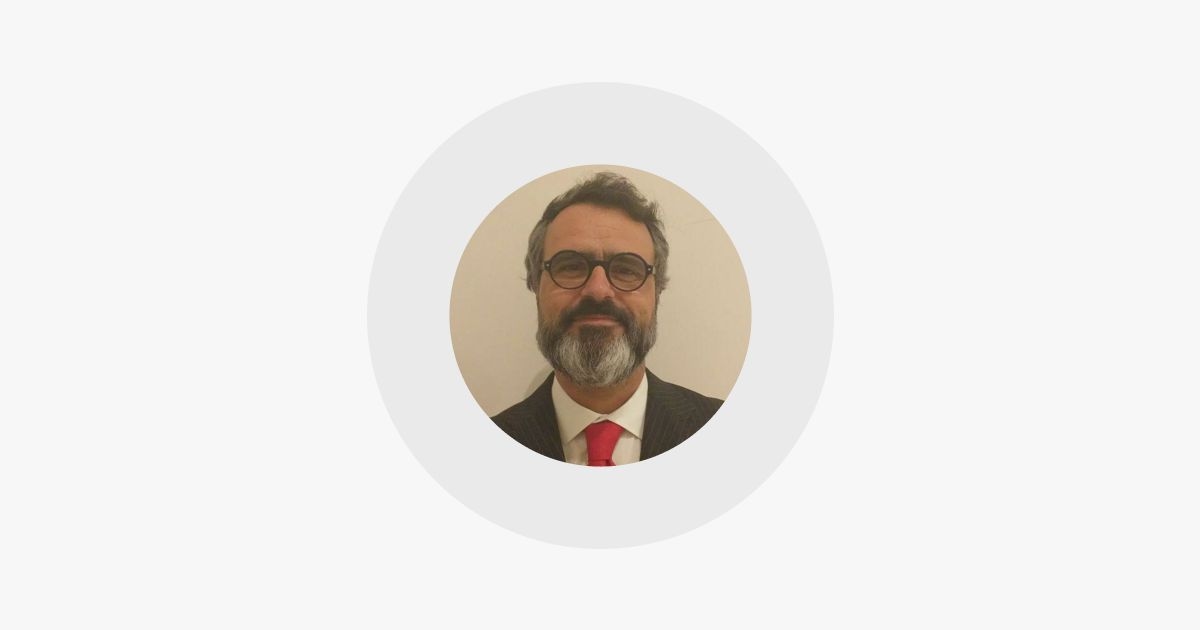
Quando arriva, la tristezza fa un rumore simile a quello delle nuvole che all'improvviso ricoprono una giornata di sole: assolutamente nessuno. Chi ha mai sentito il rumore di una nuvola che passa? Non ci accorgiamo di nulla e, all'improvviso, senza rendercene conto, ci ritroviamo al buio. Quando siamo tristi, l'anima diventa annebbiata e oscura; è una luce che si spegne all'improvviso, come il filamento di una lampadina che, senza alcun rumore, scoppia.
Nacque nel 39 o 40 d.C., in una piccola cittadina della Tarraconense, Bilbilis, sulle rive del Salo. Nel 64 partì per Roma. Rimase lì per trentaquattro anni. Per lungo tempo abitò al terzo piano del Quirinale. Poi, verso la fine dei suoi giorni, acquistò una piccola casa lì vicino (vicino al tempio di Flora). Possedeva anche, molto prima, una piccola fattoria circondata da campi e vigneti, nei pressi di Nomentum, con tegole malconce e che produceva un vino un po' mediocre.
Viaggiò poco. Soltanto la capitale lo affascinava. Leggere poesie, fare bagni caldi, frequentare “gruppi” – circoli, librerie, riunioni di studiosi e poeti, banchetti –, chiacchierare sotto i portici, rispondere alla salutatio, erano i suoi passatempi. Mai sposato.
L'anno in cui arrivò a Roma, vide metà della città in fiamme. Fu testimone della morte di Seneca, della costruzione della Domus Aurea, della morte di Nerone, delle rivoluzioni che consegnarono l'impero a Galba, Otone, Vitellio e ai Fabiani. Salutò tutti.
Ha ricoperto di elogi i “peggiori”. Era cliente di tutti i protettori che pagavano. Ha elogiato i whistleblower. Mi piacevano quelli che, nei giochi, erano più crudeli. Né Silio Italico, né Regolo, né Atedius Melior, né Arruntius Stella lo ricoprirono d'oro. Da loro non ricevette altro che lo stipendio mattutino. Si lamentò e pianse per il tempo di Augusto e per la memoria del suo ministro Mecenate. Si rivolse all'imperatore. Adulava Domiziano. Era un caro amico di Giovenale. Ebbe una certa amicizia con Plinio il Giovane. Non era amico di Tacito.
Aveva una folta barba, capelli lisci, una voce forte e profonda, e l'Hispania trasudava da ogni poro del suo corpo. Non scriveva come si faceva allora; al contrario: appassionato di precisione, di laconicismo, cercava l'espressione più appropriata e semplice, l'episodio più sorprendente, il più asciutto. Disprezzava la poesia del suo tempo: la declamatio e la mitologia. Rispetto alla letteratura del primo secolo, la sua opera è la più unica che si possa immaginare. Contrasta non solo con la precisione del suo vocabolario, con il suo odio per l'eloquenza e l'immagine, ma anche con la fermezza e la virulenza della sua espressione. Una sorta di classicismo che diventa barocco attraverso la pura purezza.
Demetrio, un giovane schiavo di sua proprietà, copiò attentamente gli epigrammi da lui composti e li offrì a coloro di cui era pupillo. Fu grazie alla sua penna che il significato della parola epigramma subì la sua fondamentale metamorfosi. Da “breve poesia” è diventato sinonimo di “arguzia tagliente e pungente”. Specializzandone il significato, specializzò anche la forma. Scena chiara e vivida, aggressivamente ossessionata dalla «battuta finale», dal «colpo»; in latino l' aculeus, l' acumen, il mucro.
Allo stesso modo, fu grazie alla sua penna che la poesia divenne una forma, per quanto erudita e saggia, di presa in giro. Il carattere singolare di quest'arte si incarnava nella brutalità del linguaggio, in un'espulsione sonora, in uno sputo sonoro, nella ricerca di parole robuste, rozze, contrastanti, nella bruschezza, nel dettaglio, nella brillantezza delle scene più vivide, nella creazione dell'oggetto più riposto, nell'espressione più ritirata: la vita a Roma catturata in un libro. Nel libro X: «Hominem pagina nostra sapit», «La mia scrittura ha il sapore dell’umano». Ecco perché gli studiosi non smetteranno mai di studiarlo: lo specialista di fiammiferi di zolfo, lo specialista di cristalli di vetro, l'amante di oggetti archetipici, i venditori di piselli bolliti e salsicce fumanti.
Pubblicò le sue raccolte di epigrammi in formato volume . Quinto Pollio Valeriano, Secondo, Atretto e Trifone curarono i suoi libri. Atrectus possedeva un'imponente bottega nei pressi del foro di Cesare, sulla cui facciata erano esposti i nomi degli autori più prestigiosi dell'epoca. Vendeva opere di lusso, le cui copertine erano accuratamente lucidate con pietra pomice e lumeggiate in viola. Trifone vendette Xenia per due sesterzi, mentre Atretto aveva messo in vendita un libro di epigrammi per quattro dinari. Ebbe successo. Veniva letto sulle rive del Danubio, sulle rive del Reno, in Bretagna. Lo lessero tutte le città dei Galli.
A Nomentum osservò il viale di bosso, i melograni nel giardino, il muretto. L'amarezza non diminuì. La dipendenza, la schiavitù ai canoni romani, a se stessi, alle letture fatte, al desiderio di scrivere, al fastidio del rumore, delle ore, delle delusioni, dei ricordi, degli amici, pesavano sull'anima fino al disgusto. L'isolamento stesso, il senso di povertà, la vanità di ogni cosa, erano più evidenti.
Nell'88 pensò di lasciare Roma. Pensò di vivere a Ravenna, ad Aquileia, ad Altium. Ritirare. Con l'arrivo di Nerva, con l'adozione di Traiano, dovette andarsene. Ritornò in Hispania.
Plinio il Giovane pagò il suo viaggio. Tornò a Bilbilis felice. All'inizio gli piaceva molto non svegliarsi prima delle nove, non dover indossare la toga e scaldarsi con la legna di quercia. La vedova Marcela gli donò una proprietà più grande e un reddito più vantaggioso di quelli che aveva ottenuto da Nomentum. Gli diede un piccolo bosco, un roseto, un lago recintato, una colombaia bianca.
Nel 98 ero a Bilbilis e mi mancava Roma. Nel 98, scrisse a Terenzio Prisco: «Se c'è qualcosa di piacevole nei miei libri, è stato il lettore a dettarmeli [ dictavit auditor ]. Mi mancano le orecchie della capitale. Mi mancano quelle riunioni in cui si è così soddisfatti da non rendersi conto di quanto siano utili...». Nell'ultimo libro che scrisse, enumerò dettagliatamente le compensazioni che Roma offriva allo scrittore, ben oltre il disprezzo che gli dimostrava e la vita appena sopportabile che lo costringeva a condurre. Offreva un pubblico, amici, elogi, buoni libri, nemici, discussioni, cattivi libri, la durezza del linguaggio, il gusto di essere informato, opere straniere, la raffinatezza e la prontezza del pensiero e, soprattutto, i piaceri delle grandi città: solitudine, anonimato, circoli di lettura, mortificazione, biblioteche, teatri. «Tutti questi grandi vantaggi che – scrisse a Terenzio Prisco – mi dispiacevano a torto quando avrei potuto goderne, non posso farne a meno ora che li ho perduti».
In latino, tristitia era il nome di un giorno di pioggia: tristis era il nome del cielo quando fa buio. Ma anche di un frutto colto dall’albero troppo presto, “amaro”. Un'albicocca dall'aspetto delizioso, ma dal sapore pungente e acerbo.
Volevo morire a Roma. Né la fortuna, né l'età, né il tempo glielo permisero. Rimase nella città in cui era nato. Il secolo passò (se era possibile che quello che lui non sapeva essere il secondo secolo d.C. fosse già passato). Continuò a invecchiare lì, aveva più di sessant'anni. Una lettera di Plinio a un amico continua ad annunciarci la sua morte, attraverso i secoli. Il suo nome era Marco Valerio Marziale e morì in un giorno di maggio come oggi, scegliendo le parole non dal dizionario della parola, ma da quello del silenzio.
observador