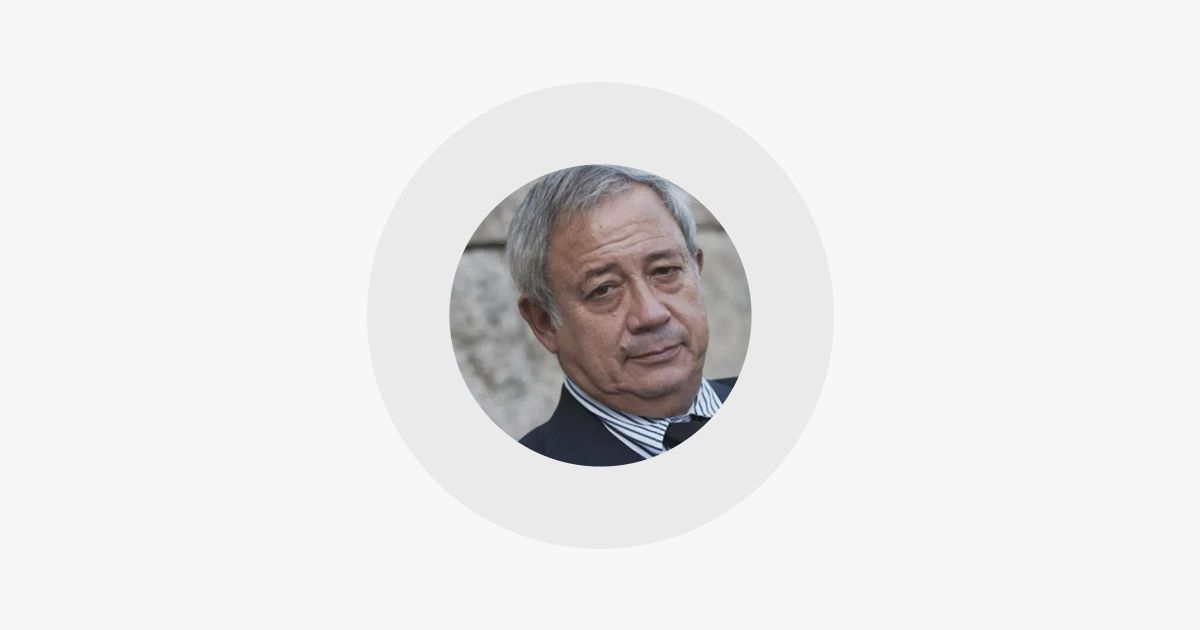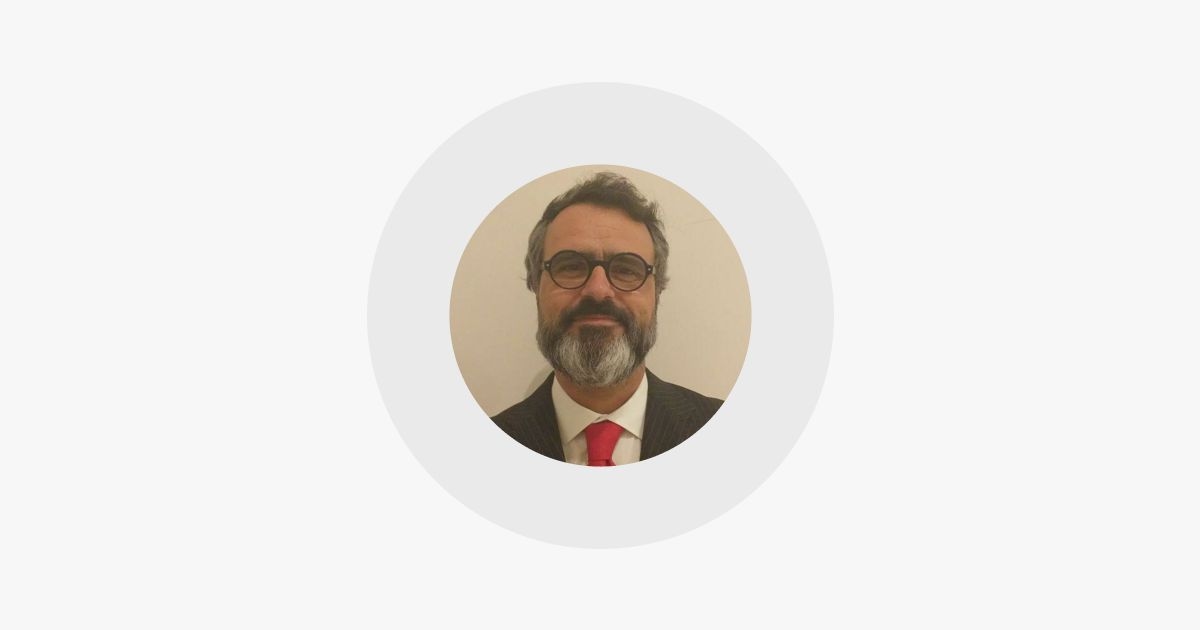La verità del bene e del male: la teoria dei giochi

La moderna teoria dei giochi svela un profondo paradosso al centro del comportamento razionale: le azioni localmente ottimali per gli individui spesso portano a risultati globalmente subottimali. Nel dilemma del prigioniero, l'agente razionale sceglie di confessare il crimine; Tuttavia, se entrambe le parti collaborassero, la situazione sarebbe migliore. Questa tensione non si limita ai giochi teorici, ma permea le interazioni reali in economia, politica e relazioni personali. L'intuizione di questo saggio è che la risoluzione di questo paradosso non è meramente strategica, ma ontologica: se il comportamento basato su principi supera il comportamento razionale nel tempo, allora quei principi riflettono qualcosa di vero sulla struttura sottostante della realtà, anche se non è visibile all'occhio.
Razionalità e limiti dell'ottimizzazione
La base della teoria classica dei giochi è l'agente razionale, definito come colui che massimizza l'utilità attesa sulla base delle convinzioni sulle strategie degli altri. Questa definizione genera equilibri stabili, ma spesso a scapito del benessere generale. Il dilemma del prigioniero e la tragedia dei beni comuni dimostrano che la defezione reciproca può essere razionale a livello individuale, ma disastrosa a livello collettivo. Anche le partite ripetute, se non attentamente strutturate, possono sfociare in circoli di sfiducia, ritorsione e inefficienza.
Azione basata sui principi e il gioco lungo
Poi c'è l'attore con principi: colui che agisce non in base a risultati immediati, ma su impegni interiorizzati come l'onestà, la fiducia, la lealtà o il sacrificio. Questi non sono semplici vincoli alla massimizzazione dell’utilità; sono nuovi assi strategici. Sebbene un simile comportamento possa esporre qualcuno allo sfruttamento nel breve termine, nel tempo e attraverso molteplici iterazioni consente la formazione di gruppi cooperativi che ottengono risultati migliori di tutti gli altri.
Questi gruppi operano secondo una regola semplice: la cooperazione è offerta a coloro che condividono gli stessi principi; coloro che tradiscono vengono esclusi. Ciò crea un ciclo di rinforzo positivo. Gli agenti razionali che osservano i migliori risultati del gruppo basato su principi si trovano di fronte a una scelta: rimanere isolati gli uni dagli altri con ricompense inferiori oppure adottare i principi che consentono l'accesso al dominio cooperativo ad alte prestazioni. Col passare del tempo, sempre più attori si uniscono al nucleo dei principi. Alla fine, la cooperazione basata su principi diventa dominante dal punto di vista evolutivo.
L'epistemologia della sopravvivenza: ciò che funziona deve essere vero
È qui che l'argomentazione raggiunge il suo apice filosofico. Se le strategie basate su principi superano sistematicamente l'interesse personale razionale, allora questi principi non sono né convenzioni arbitrarie né utili finzioni. Riflettono qualcosa di vero sul mondo. Una bugia non può prosperare in modo ottimale nel tempo. Se potessi, non sarebbe più una bugia, ma una verità più profonda mascherata.
Ciò suggerisce un'epistemologia evolutiva: la verità è ciò che sopravvive, ciò che sostiene la vita, ciò che resiste di fronte al caos. Un principio che porti costantemente a una prosperità a lungo termine deve essere allineato con la struttura effettiva dell'esistenza. La stabilità della cooperazione, la capacità di generare fiducia, la resilienza dell'impegno morale: questi non sono solo beni sociali, ma la prova dell'esistenza di un vero ordine metafisico, reale quanto il mondo materiale che ci circonda.
Conclusione: dalla strategia all'ontologia
Ciò che inizia come un'azione basata su principi diventa una strategia di successo. Il percorso dei principi, inizialmente rischioso e controintuitivo, si rivela non solo superiore, ma anche più vero.
observador